a cura di Domenico Licciardi
Introduzione
Riprendersi da un colpo è come risvegliarsi. Più duro dev’essere il risveglio su ciò che non abbiamo mai vissuto. Risvegliarsi ad una nuova vita, in un altro mondo, in un mondo che è lo stesso e tuttavia si è trasformato. Cosmo guasto, marcitosi per sempre. Fine di ogni inizio: anti-cosmologia, perpetua apocalisse.
La mente ed il corpo traumatizzati sono “cose” (esiste un altro nome?) che superano ogni giudizio – perfino quando si tratta di Céline, dell’antisemita e nazista Céline, che ci permette di sbirciare (non diremmo di “comprendere”, neppure di “immaginare”) la situazione e l’esperienza di un corpo che si risveglia frammentato e nel pensiero di una mente allontanatasi infinitamente da se stessa.
Trauma e letteratura: è ciò di cui vorremmo parlare, accostando a questi temi l’altro, sfortunatamente attuale, della guerra. Guerra è il titolo del romanzo postumo di Céline, pubblicato nel 2022 e tradotto in italiano nel 2023. Un libro sconvolgente, che mostra una realtà metamorfosata dal punto di vista clinico, etico ed estetico. Quel trauma ha una causa poco definita ma non in senso indeterministico, bensì, materialmente, perché è difficile decidere se ciò che ha squarciato il braccio e distrutto l’orecchio destri del giovane soldato sia stato un proiettile o una scheggia. Quel trauma ha anche un nome, o meglio più di uno: «rumore», «ronzio», «ronzii» (ma anche «mare»: «La guerra mi aveva dato un mare pure a me, solo per me, un mare roboante, rumoreggiante assai dentro la testa»[1]). Quel trauma genera ossessivamente effetti nella mente, nel linguaggio, nel corpo e nel mondo. Metabolismo puro: divora e trasforma tutto quanto.
La guerra
La guerra implica un’accelerazione del tempo. Non si tratta dei “tempi di guerra” né “della guerra”: manovre istantanee, improvvisazioni – Sun Tzu che esprime la necessità di adattarsi come l’acqua, Clausewitz che ci avvisa che il contatto con gli ostili sconvolgerà inevitabilmente ogni piano. Non c’è “arte della guerra” che tenga al realismo del racconto. Il tempo accelera perché i soldati imbrogliano. Imbrogliano perché il comando è rigido. Il comando è rigido perché la patria vuole eroi lì dove c’è solo carne, paura e qualche desiderio (soprattutto di vino e di sensualità): «In fatto di esperienza invecchiavo di un mese a settimana. È il passo che tocca tenere per non essere fucilati in guerra»[2]. I soldati nel romanzo non hanno nulla di eroico ed è in questo che consistono le loro virtù: scaltri, arguti, codardi quanto basta per offrire una rappresentazione priva di illusioni. Non sono preoccupati dal nemico esterno – alle zone urbane di Vasilij Grossman, Céline preferisce gli ospedali – ma dal nemico interno, dei propri superiori. Non evitano le pallottole degli stranieri ma quelle della condanna capitale, come conseguenza dell’accusa (facile accusa) di aver tradito. In tal senso, la guerra non è più il conflitto armato tra nazioni. È un caos dove si può vivere, dove si possono perfino organizzare cene borghesi bagnate di un buon rosso, ma dove si deve imparare a sopravvivere, a barare, solo per strappare un altro giorno di vita, un’altra ora di libertà, qualche frammento di erotismo con le infermiere che si trattengono quando le luci sono spente, sospendendo solo per qualche istante il tormento della notte.
Il caos, però, non è per tutti. Non è di tutti. Appartiene solo a chi è ferito, a chi ha combattuto, a chi è ritornato. Se c’è un confine, non è tra civili e militari. Quando parliamo dei feriti, dei combattenti, dei revenant, non si tratta solo dei soldati ma di tutti coloro che non sono agiati. In Guerra, per dirla nel modo più diretto, soldati e prostitute sono accomunati non tanto dagli incontri del caso: essi condividono gli stessi ambienti, diventano a pieno titolo una “classe”, sono classe di una società che ha perduto forse un ordine spirituale ma non le gerarchie materiali, economiche.
È ciò che si mostra nella lunga scena in casa Harnache, dove un soldato (Céline stesso), un mutilato (Cascade) e una prostituta (Angéle) portano la guerra nelle sale di una cena borghese. Non si tratta della guerra in senso storico, benché quest’ultima rimanga ben presente – per le strade passano le truppe mentre vengono servite le pietanze. Si tratta della guerra che i suoi figli hanno nel cuore: Cascade è geloso di Angéle, lei si vendica minacciandolo di morte, di dire che ha tradito. Lo scandalo in questo caso è che nessuno si scandalizzi: gli Harnache, i genitori di Céline, sanno bene che sarebbe successo, che gli ospiti avrebbero a un certo punto perso la testa, dato di matto. Sanno anche, forse, che il legame tra amore e morte si fa più esplicito durante la guerra (dico “esplicito” in senso letterale: il riferimento va alla necrofilia de L’Espinasse, un’infermiera anziana). La linea di demarcazione tra la guerra dei ricchi e la guerra dei poveri non si misura con la distanza dal fronte ma con l’incapacità, da parte dei primi, di provare una disperazione vera, autentica – una disperazione pura:
Del mio orecchio non si parlava mai, era come l’atrocità tedesca, cose inaccettabili, irrisolvibili, equivoche, indecenti insomma, che mettevano in dubbio l’idea stessa che a tutto c’è un rimedio a questo mondo. Stavo troppo male, soprattutto all’epoca non ero abbastanza istruito per individuare, sopra la mia testa immersa nel ronzio, l’ignominia nel comportamento dei miei vecchi e di tutte le speranze, ma me la sentivo addosso a ogni gesto, ogni volta che sto male, come una piovra bella viscida e pesante come la merda, la loro enorme stronzaggine ottimista, insulsa, marcia, in mezzo alle vergogne e agli strazi acuti, estremi, sanguinanti che urlavano proprio sotto le finestre della stanza dove noi ci abbuffavamo, nel mio dramma personale di cui loro non accettavano neanche tutti i cedimenti giacché riconoscerli significava disperare un po’ del mondo e della vita e loro nonostante tutto non volevano disperare di niente, nemmeno della guerra che sfilava sotto le finestre del signor Harnache a battaglioni compatti e che sentivamo rombare ancora a colpi di granata con tanto di echi su tutti i vetri della casa[3].
Questa linea di demarcazione segna per sempre la lontananza di una rottura: quella di Céline con la sua famiglia, coi propri genitori. Un odio impietoso, che si consuma nelle stanze dell’ospedale – «Io non aprivo più bocca. Non ho mai visto né sentito niente di più schifoso di mio padre e mia madre. Ho fatto finta di addormentarmi. Piagnucolando si sono avviati verso la stazione»[4]. Rancore ingiustificato, che non trova ragion d’essere se non nel fendente che spacca la biografia del narratore: Céline si riconosce nelle lettere di suo padre solo per allontanarsi da sé, da ciò che egli è stato e che, ormai, è deceduto: «Nelle lettere di mio padre c’era tutta la mia gioventù carogna che era crepata. Non rimpiangevo niente, lui era solo un lurido stronzo, apprensivo, mi faceva orrore, ma era pur sempre il mio piccolo passato di moccioso viziato quello che delineava sulle cartoline postali preaffrancate e sottoposte a censura, con frasi ben calibrate e ben tornite»[5].
Si tratta di censura o di cesura? Domanda che minaccia ogni distinzione tra storia e psicologia, tra epica e tragedia: quando non c’è più eroe, né vi sono eserciti – quando non resta che una massa di morti viventi che si trascinano tra una menzogna per gli altri e un’illusione per se stessi, allora tutte le categorie non possono che infettarsi. Impossibile separare individuo e società, il taglio o la ferita soggettivi dalle ipocrisie della civiltà. La ce(n)sura ha il potere di tagliare la carne e la carne è ciò che rimane al fondo del fondo. Non v’è più nulla che faccia da collante – la carne non è singolare né universale. In questo profondo disordine, al cuore di questo “niente” che taglia il vivente, la realtà diventa indistinguibile dalla memoria. A cena dagli Harnache, al bordo tra i feriti e gli intatti, tra il rumore delle marce che attraversano le città e l’insalubre baccano della festa, Céline crolla e rivive il proprio trauma:
Sono crollato a terra. Non c’era più niente nella sala da pranzo neanche la canzone di Cascade. C’erano soltanto i miei ronzii da cima a fondo per la casa e, più lontano, tutta la carica di cavalleria che scaracollava per la via attraverso place Majeure. Le granate da centoventi che bombardavano il mercato. Capivo bene in fondo il delirio delle cose. Per un attimo ho rivisto il convoglio, il piccolo convoglio mio, volevo seguirlo. Le Drellière mi faceva dei cenni, il prode Le Drellière… faceva quel che poteva… anch’io… [Ho corso, corso… e poi sono ricaduto][6].
Il trauma
“Ho corso, corso… e poi sono ricaduto”. Parole forse cancellate, forse censurate da Céline. Nulla di più naturale di fronte a ciò che accade, di fronte a ciò che è: il conatus rattrappito di un’intimità senza più soggetto, senza protezione. La nudità ben esposta, indifesa davanti al pericolo, alla morte, all’orrore più profondo. Non ha neanche senso capire chi, davvero, correva – se Céline, il sopravvissuto, o Le Drellière, il caduto. Il passato non conta e non perché venga meno la necessità della storia, bensì per via della caducità della memoria: «Passati tanti anni è una faticaccia ricordarsi le cose precise come stavano […]. È fetente il passato, si scioglie nella fantasticheria»[7]. Se il ricordo è troppo fragile affinché si faccia archivio, è proprio il trauma a fare da testimone. Perché il trauma – sì! – taglia la carne ma preserva il proprio istante – e il caos – del suo verificarsi, elevandolo ad evento.
Il trauma di guerra – ciò che oggi si chiama “disturbo da stress post-traumatico” o “PTSD” – si manifesta nel romanzo postumo di Céline nella forma clinica e sensibile dell’acufene. È un ronzio o un rumore di intensità variabile, come un allarme che impedisce per sempre di trovare pace, di essere ciò che si era, di stare con gli altri al di fuori di una situazione di ubriaca festività e violenza:
Con il becchino e Méconille che si chiedeva se avrebbe dovuto dirmi addio prima di trovarmi la pallottola, e il cappellano che veniva due volte al giorno a darmi l’eternità, e quegli infami ronzii che mi facevano tremare tutta la capoccia, era una vita meravigliosa, una vita di torture, un tormento da togliermi il sonno o quasi. Mai più, va da sé, avrei conosciuto la vita degli altri, la vita di tutti quei fessi che credono che il sonno e il silenzio vanno da sé, una volta per tutte[8].
Se non avessi avuto tante vertigini e nausee c’avrei fatto l’abitudine, però la notte è dura addormentarsi. Ci vuole gioia, rilassatezza, abbandono. Una pretesa che non avevo più. […]. È una cazzata la quiete dei campi per chi le orecchie piene di rumore. Allora meglio essere musicisti sul serio[9].
Là nella sala da pranzo del signor Harnach dov’eravamo si svolgeva una specie di ballo, un ballo dei sentimenti. Che andava e veniva in mezzo ai miei ronzii. Non c’era più niente di stabile. Eravamo ubriachi, tutti quanti[10].
A chi ha avuto la fortuna – l’immensa fortuna – di non avere un ronzio per la testa, di non vedere le esplosioni, di non essere un bersaglio più o meno facile tra i grandi solchi di una trincea, resta comunque il dovere di provare a sbirciare (ripetiamo questo termine) nel luogo della causa di tutto questo male. Mettersi in ascolto di una musica che resta per sempre lontana. Leggere di corpi frammentati e dei tentativi disperati di tenere insieme tutte le loro parti:
Mi ero diviso il corpo in varie parti. La parte bagnata, la parte che era sbronza, la parte del braccio che era atroce, la parte dell’orecchio che era abominevole, la parte dell’amicizia per l’inglese che era consolante assai, la parte del ginocchio che ogni tanto se ne andava per i cazzi suoi, la parte del passato che già cercava, me lo ricordo bene, di aggrapparsi al presente e non ci riusciva più – e poi ancora il futuro che mi faceva più paura di tutto il resto, e per finire sopra le altre una parte stramba che voleva raccontarmi una storia[11].
Leggere della realtà che inganna, confondendo cadaveri e speranze: «Mi sono accorto che cominciavo a non vedere più bene le cose al posto loro. Credevo di vedere un cavallo in mezzo al campo. Facevo per montagli in groppa e da vicino era soltanto una vacca bella gonfia, crepata da tre giorni»[12]. Leggere della difficoltà di tenere insieme, oltre al corpo, anche la mente: «Per pensare, anche un minimo, mi ci dovevo mettere a spizzichi e bocconi come quando due si parlano al binario di una stazione quando passa un treno»[13]. (Queste le testimonianze dirette di Céline, ferito di guerra, risvegliatosi in un mondo, in un corpo e in una testa che non sono più quelli di prima). Leggere – soprattutto – senza la pretesa di fare una nosografia medica o letteraria, senza sperare di “far luce su un sintomo”. Senza la superbia della freddezza, della distanza oggettivante, dell’obiettività. Provando a strappare la carne dalle lettere.

[1] Louise-Ferdinand Céline, Guerra, tr. it. di Ottavio Fatica, Adelphi, Milano 2023, p. 134.
[2] Ivi, p. 114.
[3] Ivi, p. 94.
[4] Ivi, p. 49.
[5] Ivi, pp. 54-55.
[6] Ivi, p. 101.
[7] Ivi, p. 102.
[8] Ivi, p. 62.
[9] Ivi, p. 82.
[10] Ivi, p. 95.
[11] Ivi, p. 30.
[12] Ivi, p. 28.
[13] Ivi, p. 27.
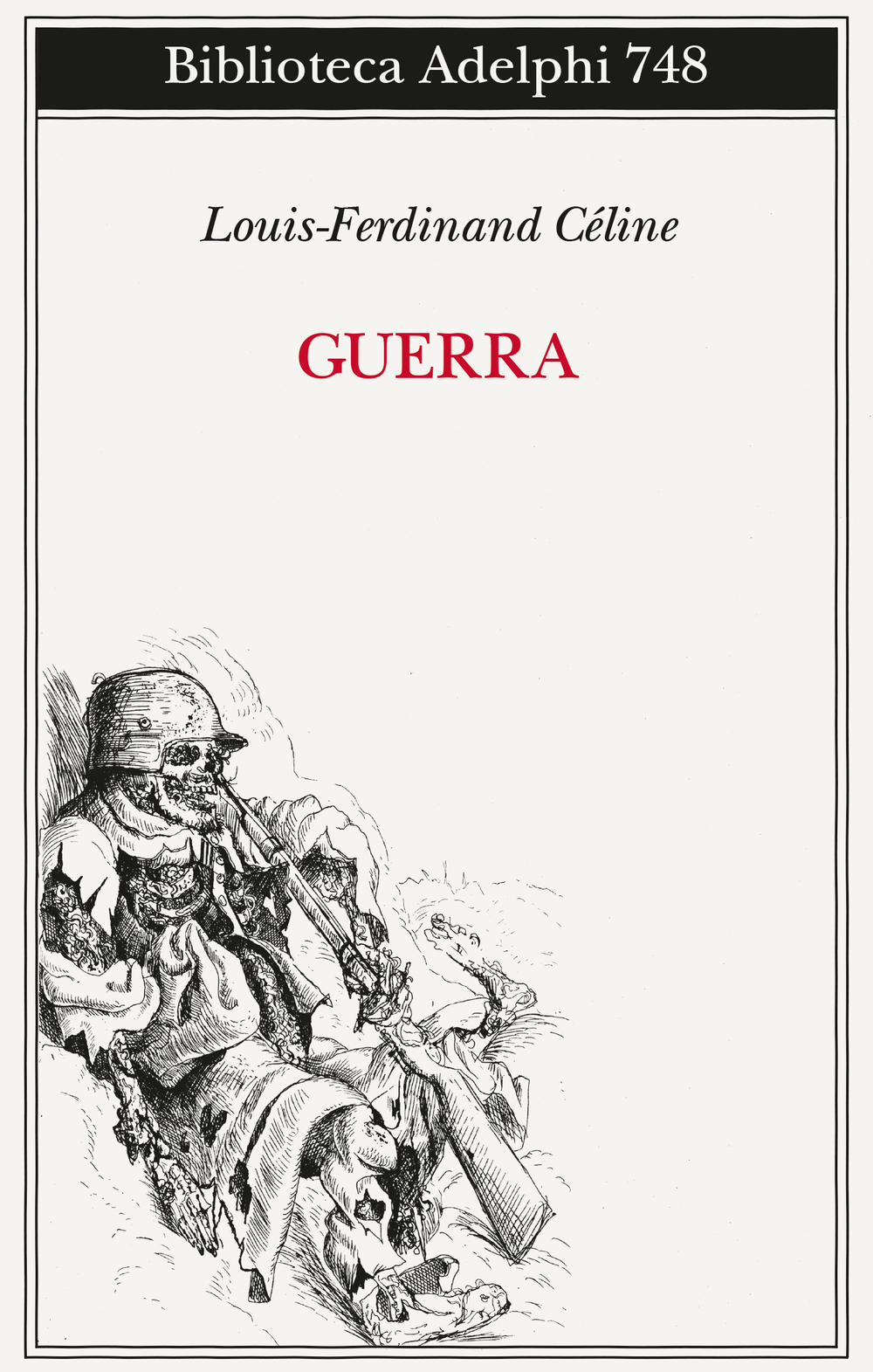
Lascia un commento