a cura di resistenza.tindalos
[L’ultima opera del regista messicano mostra la sua versione intima e meno mainstream del mostro più famoso del cinema statunitense e della letteratura: un paradossale, ma felice azzardo, per Netflix nel 2025.]
Uscito in pochissime sale cinematografiche e distribuito esclusivamente su Netflix, Frankenstein di Guillermo Del Toro è un film che travolgerà di polemiche e meme i social per ancora qualche settimana, a colpi di scene della pellicola tagliate e pesantemente editate per non incorrere nelle punizioni divine dell’Algoritmo.
Il motivo è presto detto: la Creatura del dottor Frankenstein è il simbolo più incisivo di tutto lo Zeitgeist occidentale degli ultimi due secoli, e la sua iconografia è stata resa emblematica dalla Universal nei primissimi anni del Novecento. Sfido chiunque a non applicare il paradosso dell’elefante di Dostoevkij se dico “bulloni al collo”. D’altronde, assieme al travestimento di Dracula (sempre della Universal), alla maschera di Michael Myers (o di Karl Popper Francesco Cossiga) è il costume per antonomasia, con consorte annessa, di Halloween nell’immaginario della festività.
In giro si troveranno recensioni molto più dettagliate della seguente, ma il fulcro di questo sproloquio è un altro e non ci soffermeremo su quanto sia fedele (molto, con gli ovvi e dovuti aggiustamenti) al romanzo o quanto Jacob Elordi (bravissimo) sia stato reso fedele (tanto, certo con qualche ammiccamento agli Ingegneri di Prometheus, ma di sicuro migliore del povero Robert De Niro nel 1994).
L’opera letteraria di Mary Shelley non ha certamente bisogno di presentazioni, tuttavia è bene ricordare le forti differenze tra l’edizione del 1818 e quella del 1831. Sebbene il contenuto e la sostanza da romanzo gotico non vengano stravolte, a esserlo è la vita personale dell’autrice e giocoforza la sua visione del mondo: le tragedie famigliari, come la morte di Percy Bysshe Shelley e di tre figli nel giro di un decennio, fanno sfumare l’indole ribelle giovanile tardoilluminista per favorire un approccio più maturo e fatalista alla vita.
Ciò si riflette ampiamente nell’opera: la creatura di Frankenstein, da emblema della ribellione prometeica e dunque peccato originale della scienza, indossa ora i panni delle vestigia del più cupo determinismo religioso. Victor, che in un non tanto sottinteso complesso edipico vuole sconfiggere la morte a botte di steampunk, rimane travolto dalla prima visione che ha della sua “opera”, non più tracotanza umana ma punizione divina. E in questa duplice natura simbolica Del Toro ha colto nel segno: essa viene resa in maniera impeccabile con i due differenti point of view della narrazione, quello dello scienziato e della creatura, anche se nella seconda parte si notano delle piccole ma trascurabilissime sbavature che proprio nel momento centrale del film rallentano la narrazione.
Le modifiche apportate al testo originale sono organiche non tanto per la buona riuscita del film, ma per il culmine di tutta la poetica del regista: l’enorme potenza, fraintesa come istinto violento, e al contempo il favolistico fardello della fatalità dei suoi “mostri” sono ormai rodati a tal punto che trovano in questo suo Frankenstein la forma più sintetica e intima. Abbiamo tutto in un insieme organico la tragedia di Hellboy, il rapporto burrascoso padre-figlio di Pinocchio, la sensibilità femminile verso l’altro “che non deve essere” de Il labirinto del fauno e La forma dell’acqua (anche se il ruolo di Elizabeth, anche questo rimaneggiato, passa in secondo piano rispetto al tema centrale del film).
L’intera iconografia è atta a incarnare, pezzo per pezzo, carne per carne, il film che da decenni ha sempre voluto girare sull’opera più importante della letteratura mondiale. Del Toro dirige esclusivamente per esaltare se stesso e rendere partecipe il pubblico del suo amore verso il weird e noi, sentitamente, per l’ennesima volta, in secula seculorum, ringraziamo. Da tutto ciò sorge inoltre un’ulteriore questione, quelle produzioni cinematografiche degli ultimi anni, “tenute in ostaggio” dalle piattaforme di streaming e più nello specifico di Netflix.
Questa, che nello scorso decennio ha dettato legge sulle produzioni seriali e filmiche con azzardi riusciti, non solo nell’ambito del fantastico, ma negli ultimi anni si sono viste produzioni più sicure per il portafogli e meno brillanti sul piano del rendimento e intrattenimento. Il paradosso che si è creato con il connubio tra l’azienda e Del Toro, partito con Cabinet of Curiosities e culminato con l’Oscar per Pinocchio, potrebbe essere inteso positivamente come una svolta più matura della prima ad azzardi di produzione con autori che sono una sicurezza non tanto di incassi o visualizzazioni, ma di qualità artistica.
Ma quest’ultima riflessione è solo un vaneggiamento ottimista verso futuri sempre meno rosei per l’industria: ne sono sintomi i tentativi degli ultimi giorni di scoperichiare sedicenti scandali nel backstage dell’ultima stagione di Stranger Things, e il lato fortemente votato alla dietrologia di chi scrive è incline a pensare che tutto è lecito per far pubblicità, anche da parte di rotocalchi di basso rango.
Probabilmente, se la collaborazione tra queste due entità dovesse continuare, la cartina tornasole definitiva potrebbe essere un duplice rischio registico per Del Toro: l’altro Sacro Graal della sua filmografia, ovvero Alle montagne della follia di H.P. Lovecraft, ma soprattutto, e qui siamo nuovamente nel campo dei voli pindarici, una trasposizione de Le avventure di Gordon Pym del patriarca Edgar Allan Poe. Tuttavia le intenzioni del regista sono quelle di mollare la presa su questa prima lunghissima fase della sua carriera verso lidi più “umani”, e il nostro cuore spezzato continuerà a vivere.
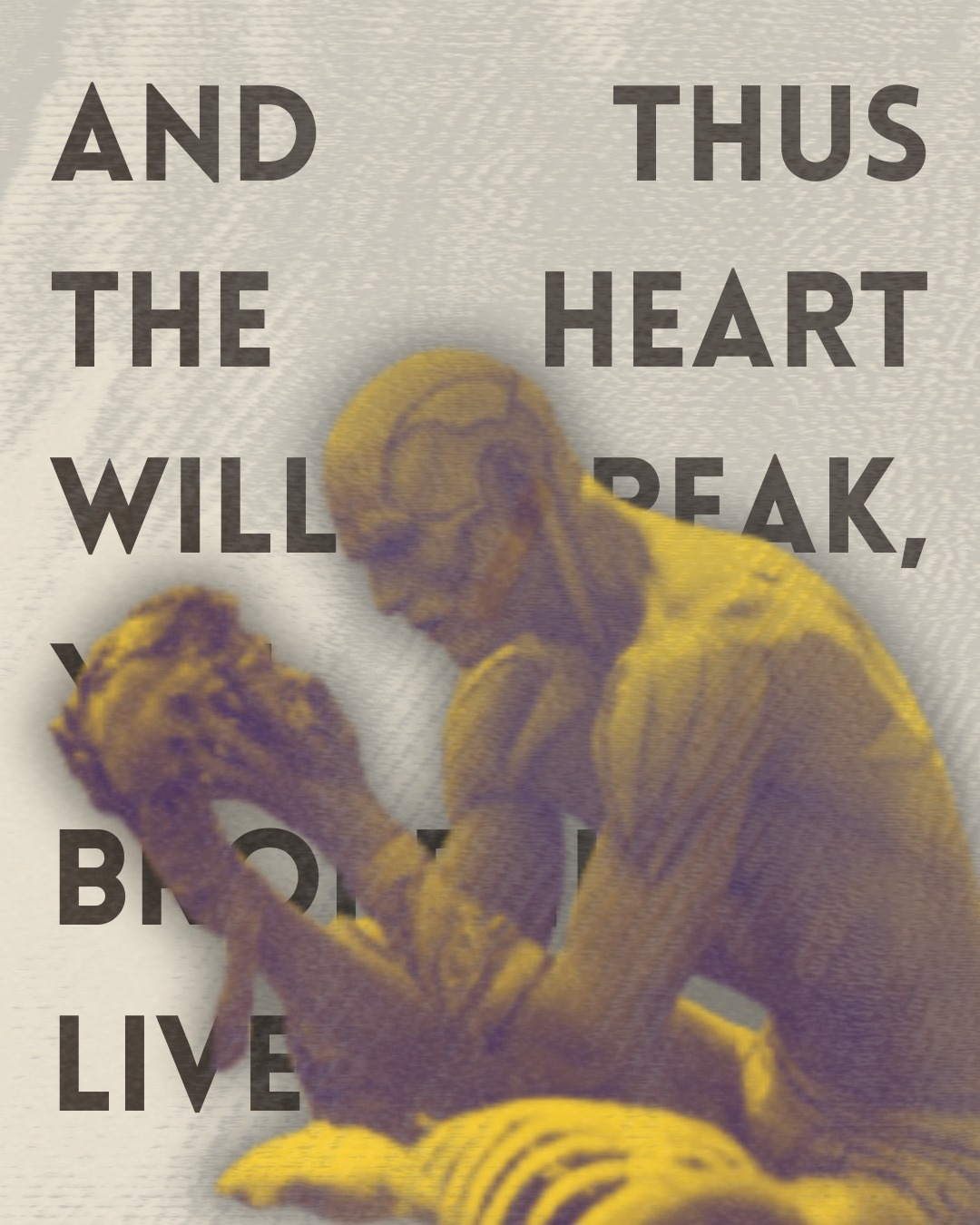
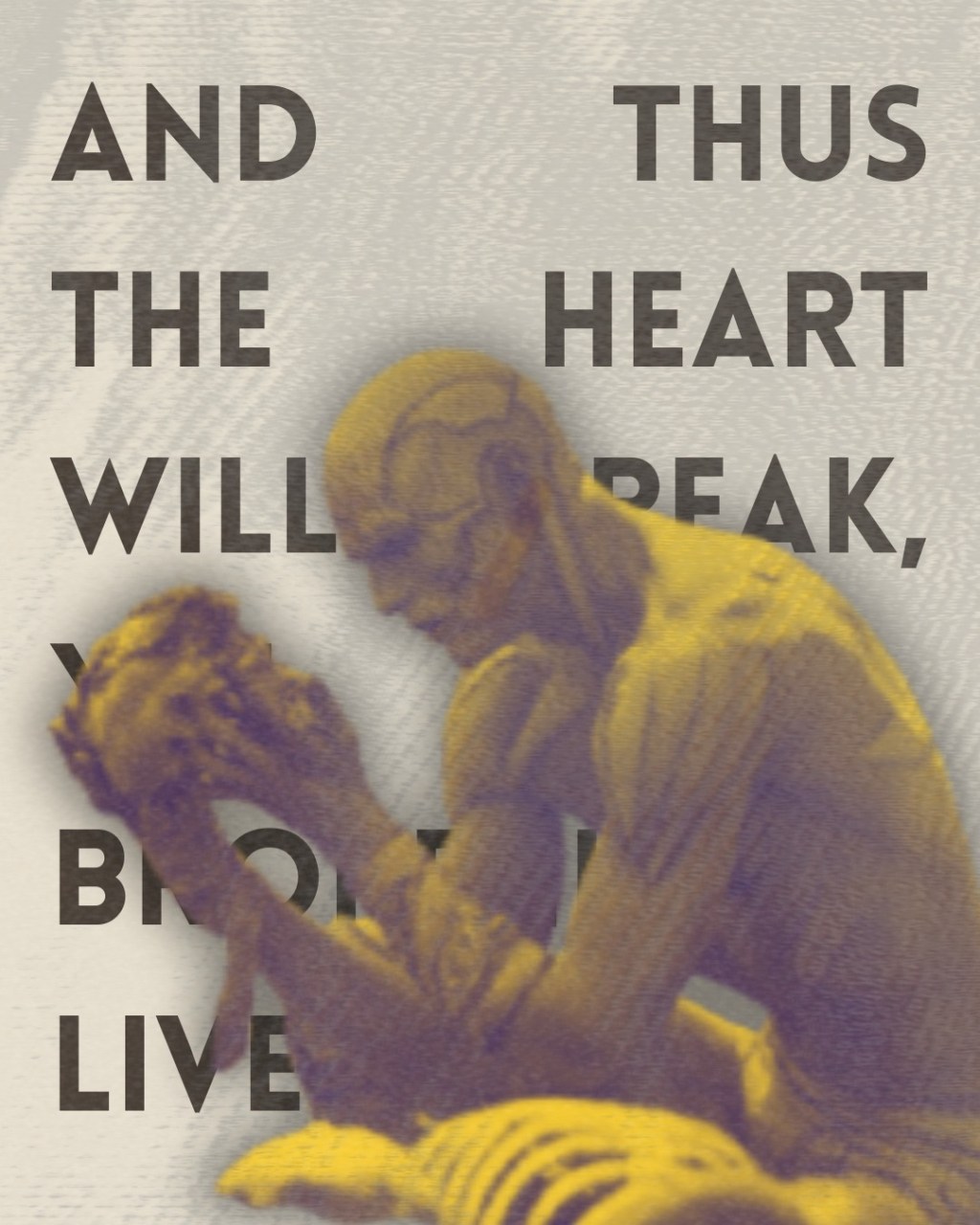
Lascia un commento